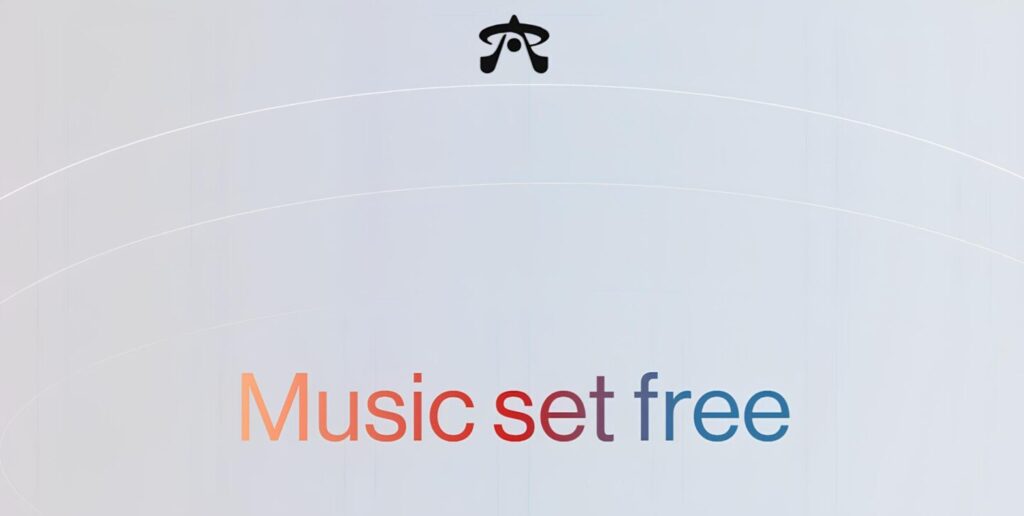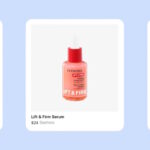Mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, si è tenuto “Orbits – Dialogues with intelligence”, evento dedicato all’intelligenza artificiale organizzato da Action Agency di Manuela Ronchi e condotto dal professor Luciano Floridi. La cornice scelta per la seconda edizione del progetto è stata quella del Palazzo del Ghiaccio di Milano.
La due-giorni si è aperta mercoledì mattina con lo show-how del noto filosofo, che ha introdotto il pubblico al concetto di capitale semantico, la conoscenza che ci permette di interpretare noi stessi e il mondo che ci circonda. Tema fondante e fil rouge dell’iniziativa dedicata a imprese e scuole.
I temi trattati all’interno dell’articolo
Cos’è il capitale semantico
Floridi propone una definizione semplice e potente: capitale semantico è tutto ciò che aumenta la nostra capacità di dare senso e significato al mondo. Un elemento fondamentale in una società post-AI.
Non si tratta solo di “contenuti” astratti, ma di libri, immagini, film, musica, tradizioni, simboli, ma anche esperienze personali, storie di famiglia, linguaggi professionali. Tutto ciò che, quando lo incontriamo, ci aiuta a semantizzare la realtà: a capirla, interpretarla e rileggerla.
Un contenuto non è mai solo un pacchetto di dati con sintassi e struttura. Diventa capitale semantico solo quando incontra una persona che lo percepisce, lo interpreta e lo integra nella propria storia.
Le macchine, spiega Floridi, non possono avere capitale semantico. Possono rielaborare contenuti, ma non vivono esperienze, non soffrono e sicuramente non si riconoscono in una narrazione. È l’essere umano, con il suo “granello di sabbia” – dolore, limite, fatica – a trasformare l’informazione in una perla di significato.
Risonanza stocastica: quando dati e AI fanno emergere il senso
Floridi usa un’immagine scientifica: la risonanza stocastica. Talvolta, quando due fenomeni “negativi” si sommano, accade qualcosa di inatteso: il segnale vero emerge più chiaramente.
Nel digitale, accade qualcosa di simile. Da una parte abbiamo una massa immensa di dati (chi siamo, ciò che produciamo, le nostre tracce nel tempo). Dall’altra l’intelligenza artificiale, che funge da interfaccia tra noi e questi dati e amplia enormemente ciò che possiamo fare.
L’incrocio può far emergere, per contrasto, proprio il nostro capitale semantico come ciò che davvero ci distingue. E ritorna la metafora della perla, utilizzata più volte da Floridi nel corso dello show-how: il granello di sabbia irrita l’ostrica, ma senza quel fastidio non ci sarebbe nulla attorno cui costruire. Così le sfide tecnologiche, pur generando frizione, obbligano a chiarire che cosa, per noi, ha davvero valore.

Capitali semantici diversi: immagini, miti, narrazioni
Il capitale semantico non è universale: cambia a seconda dei contesti culturali. Un esempio è dato dalle rappresentazioni di sant’Agostino: nero nelle raffigurazioni brasiliane, bianco in molte iconografie europee. Lo stesso santo, ma inserito nel contesto di capitali semantici diversi, che rispecchiano storie e sensibilità differenti.
Un altro esempio offerto da Floridi mercoledì mattina è la serie “The Sandman” su Netflix: la pop culture che gioca con riferimenti mitologici (Orfeo), cinematografici (“Black Orpheus”) e fumettistici. Alcuni spettatori riconoscono immediatamente i rimandi, altri no o solo alcuni. Il capitale semantico personale determina quindi la profondità con cui l’opera viene compresa.
Lo stesso contenuto può essere superficiale per qualcuno e un abisso di significati per qualcun altro. Dipende dal serbatoio di capitale semantico con cui lo si incontra. Per questo, ricorda Floridi, i classici sono fondamentali: non solo fonti (sources), ma risorse (resources). Ogni rilettura di un grande libro produce significati nuovi, perché noi cambiamo nel corso della nostra vita attraverso l’esperienza e l’apprendimento. I classici, che sulla carta restano immutati, accumulano capitale semantico nel tempo e continuano a restituirne.
Anagnorisi: quando i fatti restano uguali, ma il senso cambia
Floridi richiama così il concetto di anagnorisi (o agnizione), il passaggio dall’ignoranza alla conoscenza trattato da Aristotele nella “Poetica” ed esemplificato dal mito di Edipo. I fatti della sua vita non cambiano: ha ucciso un uomo e ha sposato la regina. La svolta, però, arriva quando scopre che quell’uomo era suo padre e la regina è sua madre.
Il capitale semantico nasce qui, nella reinterpretazione. Gli eventi rimangono identici, ma il loro significato cambia radicalmente. Da quel momento non possiamo più raccontare la storia di Edipo come prima, ci portiamo addosso questa nuova lettura.
Ed ecco il punto cruciale: se non aggiorniamo continuamente il nostro capitale semantico, il mondo cambia e noi no. Restiamo indietro e non riusciamo a riadattarci.
I rischi: perdita, improduttività, abuso, deprezzamento
Floridi individua poi almeno quattro minacce al capitale semantico. La prima è la perdita: vandalismi, propaganda, fake news, revisionismi tossici, tutto ciò che distorce o cancella significati preziosi. Così si perde memoria, si perdono sfumature, si perdono storie.
La seconda è l’improduttività, cioè il caso di un’enorme ricchezza culturale non utilizzata o usata male: manoscritti inaccessibili, archivi non digitalizzati, conoscenze disperse. Un patrimonio che potrebbe generare valore e invece resta inerte.
Segue l’uso improprio, quando simboli o eventi vengono caricati di significati che li tradiscono. È il caso di Capitol Hill, dove immagini e simboli istituzionali sono stati piegati a narrazioni distorte. Una vera e propria forma di violenza semantica.
Infine c’è il deprezzamento: il capitale semantico invecchia se non ci sono educazione, formazione e aggiornamento. In questo modo nascono cliché stanchi. La missione della cultura è proprio evitare questo deprezzamento, tenendo vivi i significati.
Controllare il linguaggio per controllare il pensiero
“Chi non controlla il linguaggio non controlla il pensiero, e chi non controlla il pensiero non controlla il capitale semantico”. Per Floridi, una delle competenze cruciali oggi è imparare i linguaggi con cui parla l’informazione: dall’arte alla zoologia, dalla notazione musicale alla statistica.
Ma non basta dire “insegniamo Python”. Così rischiamo di ripetere lo stesso errore fatto qualche anno fa con l’HTML, confondendo il linguaggio del momento con un alfabeto strutturale. Ci sono infatti linguaggi costitutivi (come il concetto di numero), quelli semplicemente notazionali (numeri romani) e quelli computazionali (i numeri arabi, che abilitano il calcolo).
Chi domina questi tre linguaggi domina il modo in cui l’informazione viene organizzata e, di conseguenza, le modalità in cui il significato può emergere.
Esperienza, dati e il problema del “grounding”
Floridi ricorda poi che, in quanto esseri umani, abbiamo un triplo accesso al mondo e all’informazione. Possiamo toccare la neve e imparare che è bianca osservandola (esperienziale); se non l’abbiamo mai percepita in prima persona, magari scopriamo che è bianca leggendo un libro o guardando un documentario (predicativo); oppure, oggi, possiamo chiederlo direttamente a ChatGPT o ad altri chatbot.
Nella società digitale, la quantità di dati cresce in modo vertiginoso. Sorprende pensare che tutto ciò che la nostra civiltà ha prodotto fino al 2010 equivalga a circa 2 zettabyte, mentre si stima che in soli 15 anni, dal 2010 ad oggi, ne siano stati generati oltre 180. Per navigare in questo oceano informativo, ci affidiamo sempre più alle macchine e ai modelli di linguaggio di grandi dimensioni, come quelli alla base di molti chatbot, che ci permettono di reperire informazioni in pochi secondi, ma – sottolinea Floridi – sono “pappagalli stocastici”. Producono risposte plausibili calcolando la probabilità che certi token (sezioni di parole) siano concatenati in un certo modo, non si basano su verità vissute.
Per una macchina, “la neve è bianca” è una conclusione statistica. Dopo “la neve è”, è probabile che ci sia la parola “bianca”. Per un umano, invece, è un fatto ancorato all’esperienza. Ed ecco il cuore del symbol grounding problem: come si fondano i simboli sul mondo reale?
Da questo scollamento derivano anche le allucinazioni, risposte sbagliate ma convincenti, che non si possono eliminare del tutto perché strutturali al funzionamento dei modelli. Secondo la congettura di Floridi, se un sistema ci azzecca sempre, è simbolico, rigido, debole. O è rotto o risponde sempre correttamente, come una calcolatrice. Se invece un sistema è potente e flessibile (generativo), allora non potrà mai essere completamente certo, proprio perché si basa sulla probabilità. O potenza, o controllo assoluto.
Ma per i contesti ad alto rischio (sanità, finanza, diritti, democrazia), un solo errore può essere inaccettabile. Servono quindi strati di controllo: Floridi parla di Neuro-AI, cioè un’AI simbolica – controllabile – che controlla a sua volta quella generativa. È una soluzione praticabile su cui si sta lavorando.
Data lakes e asimmetria semantica
Se potenza di calcolo, algoritmi e denaro sono ormai ampiamente disponibili, come possiamo distinguerci? Il percorso guidato da Floridi conduce proprio qui. La vera differenza la fanno i dati. Quelli disponibili online sono già stati presi e sfruttati. Restano però i data lakes personali o aziendali, contenuti specifici e ricchi di capitale semantico.
Una startup, ricorda il filosofo, ogni anno produce gigabyte di documenti, email, progetti, riflessioni. In quell’insieme, c’è un capitale semantico che appartiene solo a lei. Se accumulato e lavorato bene, permette di “fare il vino in casa”, di avere un’AI addestrata su un patrimonio semantico unico (l’uva del proprio vigneto).
Il vantaggio competitivo non sarà più nell’asimmetria informativa (“io ho dati che tu non hai”), ma nell’asimmetria semantica: “magari abbiamo magari gli stessi dati, ma io so usarli per costruire significato meglio di te“.
Chi non ha cura del proprio capitale semantico – chi lo lascia sanguinare, disperdersi, invecchiare – sarà superato da chi lo coltiva.

Allevi: quando una parola diventa musica
Il discorso sul capitale semantico trova una testimonianza potente nella storia del maestro Giovanni Allevi, che si è unito a Floridi sul palco in chiusura di una mattinata ricca di spunti di riflessione.
Da giovane, racconta, si era appassionato al modo in cui Bach inserì il proprio nome in musica in “L’arte della fuga”, trasformando le lettere in note. Anni dopo, quella stessa idea si è trasformata in un’ancora di salvezza.
Il 2 giugno 2022, durante un concerto a Vienna – racconta Allevi dal palco di Orbits -, un dolore alla schiena insopportabile lo costringe a fermarsi. Poco dopo arriva la diagnosi: mieloma multiplo, tumore del midollo osseo, in stadio avanzato.
Dopo lo shock iniziale, Allevi si pone una domanda “semantica”: che melodia può nascere da questa parola? Trasforma così “mieloma” in una sequenza di note, e da lì in un’opera per violoncello, “MM22”. Un diario in musica della malattia che riesce però a distrarlo dalla stessa. Una parola che, invece di essere una condanna, diventa l’origine di un processo creativo.
È un esempio limpido di capitale semantico: lo stesso contenuto può essere una sentenza, oppure diventare anche materia di musica, di arte. Un nome temibile può essere reinterpretato quasi sinesteticamente e al prodotto di questo processo può essere attribuito – da chi ne conosce l’origine – un significato profondo.

Vivere in una società post-AI: una responsabilità semantica
In una società post-AI, la questione non è più se usare l’intelligenza artificiale, ma come. Il punto non è difenderci dalla tecnologia, ma decidere che cosa vogliamo fare emergere con essa.
Il capitale semantico va curato, creato e trasmesso. Ma la sfida non è solo tecnica, è profondamente culturale. Solo così potremo usare l’intelligenza artificiale senza delegarle il compito di generare senso e trasformare i nostri “granelli di sabbia” in perle di significato da condividere e arricchire.
L’intelligenza artificiale può spremere l’uva dei dati meglio di chiunque altro. Ma decidere che cosa è vino buono e perché vale la pena berlo resta una responsabilità tutta umana.
➡️ Leggi qui i comunicati sull’evento:
LEGGI ANCHE 👇
L’articolo sulla prima edizione di Orbits al teatro Alcione (settembre 2024):

L'AI ha fatto divorziare la capacità di agire e l'intelligenza: la nuova umanità secondo Floridi
Luciano Floridi, a teatro, ha esplorato la natura umana, contrapposta,…
La nostra intervista a Luciano Floridi (settembre 2024):

I modelli generativi inquinano l'informazione? La nostra intervista a Luciano Floridi | AI Talks #13
La nostra intervista a Luciano Floridi, già professore di filosofia…